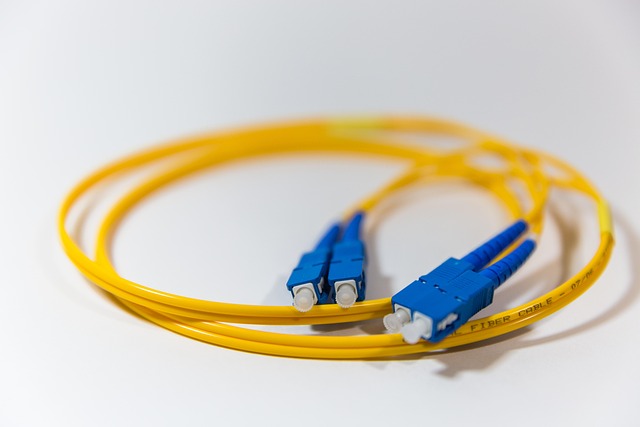Lo strano caso WeWork: il R.E. è nudo?

Fonte: autori, Huffington Post
E’ successo tutto in pochi giorni: WeWork, la società che ha (avrebbe?) rivoluzionato il mondo dei luoghi di lavoro condivisi, dopo avere visto dimezzare la propria valutazione in pochi mesi passando da 47 a 20 miliardi di dollari, proprio a ridosso della sua imminente IPO (Initial Public Offering) ha prima deciso di rimandare il proprio sbarco in Borsa e poi, siamo a queste ore, di spingere il suo founder e CEO, il magmatico Adam Neumann, a rinunciare ad ogni incarico operativo.
Bene: ma perché la cosa ci dovrebbe interessare e, persino, interessare molto?
Per una serie di buone ragioni, in ordine sparso:
– L’IPO di WeCompany – società madre di WeWork – sarebbe un tricorn (azienda che si quota con un valore superiore ai 10 miliardi di dollari),la più importante dell’anno dopo quella effettuata da Uber;
– l’esperienza di lavorare in elettrizzanti coworking sta diventando ormai un tratto tipico del nostro tempo e sarebbe un peccato smettere di sognare, ed elettrizzarsi;
– soprattutto, WeWork si era ripromessa sommessamente di “elevare la conoscenza del mondo” cambiando il modo di lavorare sin qui conosciuto e di essere la prima tech-company (leggi: AirBnb, Amazon, Facebook, etc.) del mercato immobiliare, di cambiarne finalmente – e definitivamente – i connotati.
Dove (se) si è rotto l’incantesimo?
Si è parlato della complicata e un po’ nebulosa struttura societaria di We Company. Si è posta ovviamente molta attenzione anche sul pauroso indebitamento della società che, solo dall’inizio dell’anno, ha perso 900 milioni di dollari. Un fattore importante, certamente, ma tutt’altro che unico nel panorama delle tech-company (“Dov’è il problema? Uber ne ha perso 14 miliardi in 10 anni. Siamo in linea…”).
Tutto vero. Ma il cuore, meno evidente e più profondo, il fattore strutturale, storico, direi quasi ontologico, della vicenda è un altro. Sembra che il mercato stia dicendo:
“Cara WeWork: sei bellissima, sei innovativa, crei degli ambienti veramente creativi, fai incontrare un mucchio di gente interessante. Sei davvero molto figa, insomma, ma NON sei una tech-company.
Indossi abiti bellissimi ma sotto il vestito il R.E. è nudo!”.
Sia chiaro: il “modello WeWork”, che sta facendo proseliti in giro per il mondo (da noi si guardi i “Giardini del talento” di Dattoli), è davvero molto ben pensato e molto innovativo. Oltre ad essere location eccezionali, nei WeWork lo spazio di lavoro si sceglie in qualche modo “à la carte”, orientandoti volta per volta sulle necessità, sulle utilities spaziali, tecnologiche o sulla community che vuoi incontrare.
Ma il punto davvero interessante, a prescindere dai dubbi finanziari e dalle biografie dei personaggi coinvolti, è capire se tutto lo scintillante racconto alle spalle di WeWork si riduca ad una “semplice”, per quanto ben pensata e realizzata, operazione immobiliare. Addio quindi – questo il punto – a sogni di profitti esponenziali tipici delle tech-company.
Un bluff quindi, per quanto innovativo? Non direi. Ma qualche domanda vale la pena porla.
Per rispondere, bisogna porsi due domande.
Prima domanda.
WeWork ha rivoluzionato davvero il mercato immobiliare? Ovvero:
WeWork è una tech-company?
Vediamo. Cosa fa WeWork. Sintetizzando grezzamente: affitta spazi da proprietari e, dopo un’accurata ri-brendizzazione, un innesto massiccio di dotazioni tecnologiche di ultimo grido e l’organizzazione di un interessante palinsesto di eventi, li rende disponibili capillarmente in un mercato multi-tenant. È un po’ come se Uber avesse deciso di prendere le macchine dei suoi iscritti, cambiarne gli interni, riempire di adesivi l’esterno, agghindare gli autisti con divise di ordinanza e dotarli di smartphone aziendali di ultima generazione.
Figo, ripetiamo, molto innovativo. Ma anche rivoluzionario?
A differenza delle tech-company quindi, WeWork:
– ha alti costi fissi ma non bassi costi variabili (gli affitti), che aumentano con l’aumentare del fatturato.
– la tecnologia ha una funzione importante, migliorativa, ma pur sempre ancillare rispetto al modello di business. Non guadagna da un software, dall’advertising, da fee su transazioni etc.
– non è una piattaforma di intermediazione two-side, ma fa da agente per i proprietari.
La risposta quindi è no. WeWork non è una tech-company. E il mercato sembra pensarla allo stesso modo.
Seconda domanda.
Il caso We Work significa che il mercato del Real Estate è impermeabile alle piattaforme? Ovvero:
è possibile una tech-company del Real Estate?
La vicenda che stiamo raccontando sembra confermare una sensazione: come lo giri lo giri, il mattone è una cosa solida, seria, concreta, pesante. Lo puoi rivestire come ti pare, ma non prenderà mai il volo.
WeWork ci ha provato ad agganciare saldamente il “tech” a questo mercato. Nelle sue dichiarazioni è presente in maniera netta e pervasiva il ruolo centrale della tecnologia. Il documento di preparazione all’IPO recita:“Offriamo ai nostri membri un accesso flessibile a splendidi spazi, una cultura di inclusione e l’energia di una comunità ispirata, il tutto collegato dalla nostra ampia infrastruttura tecnologica”.A ben guardare però, sembra che la tanto e tanto giustamente decantata “infrastruttura tecnologica” sia finalizzata a vestire in maniera innovativa gli immobili e la loro fruizione più che a trasformare – al di là delle dichiarazioni – lo spazio in servizio.
Space as a service. Questa la chiave.
Trasformare lo spazio in uno dei servizi cui accedere in base alle necessità che la tua attività via via richiede. Questo deve essere il ruolo trasformativo della tecnologia; così si può “liberare” il real-estate, rendere lo spazio “liquido” ed aprire davvero il sentiero alle tech-company del settore.Senza annoiare ulteriormente i pochi che hanno avuto l’ardire di seguirci fino a qui, in conclusione poniamo alcune possibili “mile-stones” per percorrere questa strada:
. Two-side platform. Si deve unire davvero i due lati del mercato, essere intermediari senza “prendere una parte” (intermediario, non agente).
. Real Tech. La tecnologia deve abilitare lo spazio come servizio, non (solo) migliorare i servizi dello spazio.
. HR tech. Argomento di nicchia, ma molto interessante e potenzialmente ‘eversivo’. A definire le caratteristiche dello “space as a service” non devono essere solo le sue caratteristiche fisico-dimensionali ma anche quelle relazionali, rappresentabili e operabili anch’esse attraverso la tecnologia (orientare le collisioni nello spazio per aumentare il valore delle persone e delle aziende).
Ci torneremo, ma questa è la frontiera verso cui si dovrebbe dirigere chi abbia l’ambizione di compiere una trasformazione strutturale del real-estate. In questo modo può davvero aprirsi una strada non solo per cambiare abiti al RE ma forse, e finalmente, per cambiargli l’anima.
Daniele Di Fausto – CEO eFM
Emiliano Boschetto – Communication & Community Building eFM