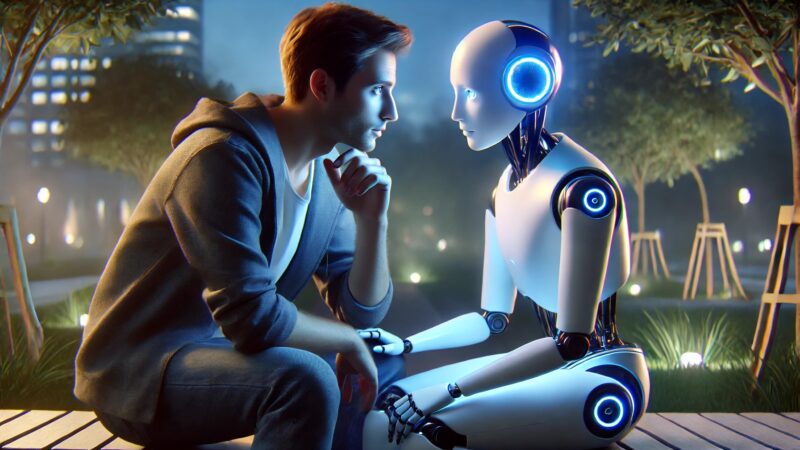Destino o Scelta? Dal Demone di Laplace ai computer quantistici

di Roberto Quattrini
“Potessi tornare indietro non farei gli stessi errori…”
Quante volte abbiamo detto o sentito questa frase? Altre volte ci convinciamo che “è già tutto scritto nel destino”. Due affermazioni tanto comuni quanto opposte nel loro significato.
La prima richiama la responsabilità, la consapevolezza della scelta e il libero arbitrio. La seconda ci vede attori di un copione già scritto, quasi a voler alleviare il peso dei rimorsi e dei sensi di colpa.
Una contrapposizione che attraversa la storia del pensiero, dalle religioni alle filosofie, dalle culture di popoli alle inquietudini delle singole coscienze.
Ma cosa hanno a che fare queste idee con la matematica, la fisica e soprattutto i computer quantistici?
Il sogno di Laplace
Potremmo tornare molto indietro nel tempo ma fermiamoci al 1814, quando Laplace ci presenta la sua visione di un universo perfettamente prevedibile, fondato sulle leggi della meccanica classica di Newton. Il suo famoso “demone” immaginario è un’entità onnisciente, in grado di ricostruire il passato e prevedere ogni evento futuro a patto di conoscere le condizioni iniziali di ogni singola particella che compone l’universo.
In questo mondo regolato da leggi deterministiche, il caso e l’incertezza non trovavano posto. Non c’è libero arbitrio, tutto è già scritto!
Questa visione del mondo è spiegata molto bene a scuola, nei primi capitoli di ogni libro di fisica. Dal moto rettilineo uniforme alle leggi della termodinamica le equazioni che modellano i fenomeni naturali descrivono un quadro ordinato e prevedibile. Il metodo sperimentale garantisce ripetibilità, causa ed effetto si intrecciano con rigore assoluto e rassicurante.
Quando arriviamo ai capitoli sulle onde il concetto comincia a farsi più sfuggente ma con Maxwell (1862) il determinismo sembra salvo e anche l’elettromagnetismo rientra nei binari della prevedibilità.
Il crollo del determinismo
Arriviamo così ai primi decenni del XX secolo e agli ultimi capitoli dei nostri libri di fisica, quelli più difficili e meno intuitivi (almeno lo furono per me!).
La storia dell’arte ci racconta del Futurismo, che in quegli anni celebra il dinamismo e la velocità rifiutando la tradizione e l’ordine. Quasi in una strana contraddizione, il “manifesto” che ne proclama “le regole” viene scritto senza punti e virgole. In quegli stessi anni anche la fisica quantistica muoverà i primi passi, prendendo le distanze dalla fisica classica e mettendone in crisi il rigore assoluto. La luce smetterà di essere solo un’onda rivelando la sua natura duale e mostrando un volto corpuscolare inaspettato. Allo stesso tempo, le particelle elementari cominceranno a comportarsi come onde, infrangendo le certezze della meccanica tradizionale.
L’esperimento delle due fenditure
Mi rendo conto che da qui in avanti e la trattazione scientifica potrebbe diventare complessa. Cercherò di rendere tutto più facile raccontandovi di un esperimento, tanto semplice quanto sorprendente: il celebre esperimento delle due fenditure, ideato da Thomas Young nel XIX secolo e poi reinterpretato in chiave quantistica. Vi lascerò il piacere (e forse l’imbarazzo) di trarre le vostre conclusioni alla fine.
Rimango meravigliato nello scoprire che nonostante sia passato molto tempo dalla sua prima ideazione, questo esperimento ancora oggi continua ad essere ripetuto in tante varianti, sfidando sempre la nostra comprensione della realtà.
Non indugiamo ulteriormente e immaginiamo di sparare proiettili contro una parete con due piccole fenditure. Nulla di strano: quelli che superano le fessure colpiscono il muro retrostante, distribuendosi principalmente in corrispondenza delle aperture. Fin qui, tutto secondo le aspettative.
Ora, però, sostituiamo i proiettili con elettroni. Intuitivamente ci aspetteremo di trovare lo stesso risultato, ma succede qualcosa di inaspettato: gli elettroni colpiranno lo schermo posto dietro le fenditure disegnando delle “bande” d’interferenza tipiche dei fenomeni ondulatori. È come se ogni singolo elettrone passasse, contemporaneamente, attraverso entrambe le fessure, comportandosi non più come una particella ma come un’onda. Già qui le nostre certezze vanno in crisi, ma c’è di più!
Se proviamo ad “osservare” (misurare) il processo, cercando di scoprire da quale fessura passa ogni elettrone, tutto cambia “magicamente”. L’interferenza scompare e gli elettroni si comportano esattamente come i proiettili, attraversando una sola fenditura alla volta distribuendosi di conseguenza. L’atto stesso di osservare ha modificato quindi la realtà. Strano ma vero!
Nasce il quantum computing
Questo esperimento dimostra che le particelle subatomiche (ma più recentemente è stato dimostrato anche con alcuni atomi, molecole e macromolecole) si comportano come onde di probabilità. Aleatorietà che perdono a favore delle regole deterministiche quando interagiscono con lo strumento di misura (avviene il cosiddetto collasso della funzione d’onda).
E’ qui che la ragione va definitivamente in crisi, può l’osservazione determinare la realtà?
Non spingiamoci oltre in questi ragionamenti controintuitivi, ma proprio questi concetti sono alla base del quantum computing, dove il determinismo della logica binaria viene sostituito dalla sovrapposizione simultanea dei molteplici stati quantistici (“qubit”), aumentando esponenzialmente la capacità di calcolo dei nuovi computer.
Immaginiamo di lanciare un dado e lasciarlo ruotare su sé stesso: finché non lo fermiamo con la mano possiamo assumere che questo assume contemporaneamente tutti e sei i valori delle sue facce. Analogamente, un qubit esiste in più stati simultaneamente finché non viene misurato, rivelando un valore preciso.
Invece di ricorrere al dado (o più frequentemente alla moneta) per spiegare il “principio di sovrapposizione degli stati quantistici”, molti di voi avranno sentito parlare del famoso paradosso del gatto di Schrödinger: un povero gatto chiuso in una scatola con un meccanismo letale. Fino a quando la scatola rimane chiusa, il gatto è in una sovrapposizione di stati: vivo e morto allo stesso tempo. È solo aprendo la scatola che definiamo la sua sorte.
Siamo spettatori o autori della realtà?
Attenzione, queste non sono bizzarrie teoriche, esistono già sul mercato sensori che sfruttano questi fenomeni e i primi computer quantistici stanno già ridisegnando i piani strategici di molte aziende e governi (specialmente per applicazioni in ambito militare).
Il quantum computing segnerà una nuova rivoluzione tecnologica seguendo il percorso delle altre innovazioni che, con ritmi sempre più accelerati, passano dalla fase sperimentale a quella di utilizzo massivo.
Ma non è solo tecnologia. La fisica quantistica ridefinisce il nostro rapporto con la realtà alimentando riflessioni profonde e quesiti ancora oggi non risolti. L’idea di un universo rigidamente prevedibile crolla: il futuro non è scritto nei minimi dettagli, ma emerge da un ventaglio di possibilità.
L’interazione tra chi osserva e ciò che viene osservato solleva domande profonde sulla coscienza e sulla natura oggettiva della realtà. Se il mondo non è rigidamente determinato, ma si sviluppa attraverso probabilità e scelte, allora anche il libero arbitrio trova la sua giustificazione.
Siamo dunque semplici spettatori o siamo autori della realtà in cui viviamo?
Link social dell’autore: www.linkedin.com/in/roberto-quattrini-pmp-psm-42820324
Immagine generata con l’ausilio di un modello AI (ChatGPT di OpenAI)
#QuantumComputing #IntelligenzaArtificiale #AI #FisicaQuantistica #LiberoArbitrio #Filosofia #Tecnologia #Innovazione #EticaTecnologica #Scienza